|
|

|
|
|
|
Distanza complessiva da percorrere
|
circa 200
Km
|
|
Tempo medio di percorrenza
|
circa
4 ore
|
|
Tempi di sosta e visita
|
circa 4 ore
|
|
Durata complessiva dell'itinerario
|
circa
8 ore
|
|
|
|
|
1. Sassari: Chiesa di
San Giacomo di Taniga.
|
|
2. Usini: Chiesa di
San Giorgio di Oliastreto.
|
|
3. Ossi: Chiesa di
Sant'Antonio di Briai.
|
|
4. Banari:Chiesa di
Santa Maria di Cea.
|
|
5. Borutta: Abbazia di
San Pietro di Sorres.
|
|
6. Torralba: Chiesa di
Nostra Signora di Cabu Abbas.
|
|
7. Bonorva: Chiesa di
San Lorenzo di Rebeccu.
|
|
8. Bono: Chiesa di San
Gavino di Lorthia.
|
Il vero Medioevo irruppe in Sardegna
proprio quando nel resto d'Europa era al tramonto. Il feudalesimo, che le era
rimasto sostanzialmente estraneo, vi venne importato a forza dalla penisola
iberica e cominciò a radicarsi nell'isola nel XV secolo, perpetuandosi poi
fino alle soglie dell'età contemporanea. I Genovesi, arroccati nei loro
castelli, resistettero per oltre un secolo (dal 1323 al 1436) all'avanzare
della conquista aragonese, appiccando dovunque l'incendio di una belligeranza
feroce, antiquaria, che devastò le campagne più fertili e di più solide
tradizioni agricole. Le incursioni piratesche, anziché attenuarsi, si
inasprirono, seminando il terrore sui litorali. Le pestilenze peggiori,
infine, erano ancora in agguato: per il Nord Sardegna la più grave di tutte
fu quella del 1652, che decimò la popolazione di Sassari, riducendola della
metà in pochi mesi. Fu sotto questi convergenti flagelli che nacque e crebbe
via via di portata un flusso migratorio dalle coste e dalle pianure verso
l'interno e verso la relativa protezione e salubrità dei rilievi. Le
dimensioni dell'esodo furono impressionanti: si calcola che circa la metà dei
villaggi esistenti nel Capo di Sopra all'inizio del XV secolo si spopolò nel
corso dei due successivi. Le chiese romaniche, intatte o in rovina, restano
sui luoghi di queste tragedie altrimenti silenziose come schiaccianti prove
testimoniali. L'itinerario che qui si propone tocca alcuni di questi solitari
custodi di una memoria fuggita altrove. Non sono che pochi esempi, allineati
lungo una linea appena un pò zigzagante, ma esplicita nella sua continuità,
che dall'agro di Sassari si addentra nel Meilogu e nel Goceano fino ai
confini della provincia di Nuoro. L'eccellenza di alcune di queste chiese
comunica con asciutta sobrietà al viaggiatore il senso di una realtà che sarebbe
difficile estrarre con altrettanta immediatezza dai documenti di carta: a
paragone dell'età moderna il Medioevo, luogo storico - letterario delle
tenebre, è stato per la Sardegna una stagione di sole.
1. Sassari: Chiesa di San Giacomo di Taniga.
L'itinerario, che presenta la sua prima meta lungo la strada fra Sorso e
Sassari e l'ultima nella valle del Tirso, all'estremo sud della provincia, è
immaginato per chi, sbarcato sull'isola a Porto Torres, debba raggiungere
Nuoro o la sua costa e sia interessato a conoscere, a prezzo di non
proibitive deviazioni, alcuni piccoli e 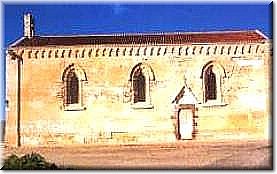 grandi
capolavori del romanico disseminati lungo il percorso, sui siti oggi
campestri di antichi villaggi scomparsi. grandi
capolavori del romanico disseminati lungo il percorso, sui siti oggi
campestri di antichi villaggi scomparsi.
Sassari: sul fianco sinistro della chiesa di San
Giacomo di Taniga si aprono tre monofore e un portale in stile gotico
La prima chiesa, ubicata nell'agro di
Sassari, fa per la verità eccezione, non trattandosi di un edificio in stile
romanico, ma gotico. Per raggiungerla imbocchiamo da Porto Torres la statale
131 Carlo Felice in direzione di Sassari e dopo pochi chilometri ne usciamo
al bivio per Sorso, che dista da questo svincolo poco più di un quarto d'ora
di strada: attraversate Sorso e la contigua Sennori, prendiamo la statale 200
per Sassari, dalla quale, ormai in vicinanza del capoluogo, una breve
deviazione a destra ci conduce alla chiesa di San Giacomo, che sorge sul sito
dello scomparso villaggio di Taniga o Tanecle, proprio di fronte ad un'altra
chiesetta, quella barocca di Santa Maria. San Giacomo rappresenta il più
significativo esempio di architettura gotica del territorio sassarese.
Costruita interamente in conci di calcare chiaro, con interno ad aula
mononavata, risale al primo quarto del XIV secolo. L'abside quadrata, voltata
a crociera, è illuminata da ampie monofore a sesto acuto. Gli spioventi della
facciata, liscia e nuda, terminano nel piccolo campanile a vela in asse col
portale gotico. Lungo il fianco sinistro dell'edificio si aprono tre alte
monofore dall'elegante profilo trilobato e un portale con architrave a
timpano.
2. Usini: Chiesa di San Giorgio di Oliastreto.
Da San Giacomo si prosegue lungo la statale 200 fino a Sassari e di qui
s'imbocca la nuova direttissima per Ittiri, che si lascia dopo pochi
chilometri allo svincolo di Usini: prima di raggiungere (abitato, si piega a
destra sulla strada che conduce all'incrocio della statale 127 bis. La si
attraversa, procedendo nella strada che si apre di fronte e che, dopo circa
cinque chilometri, porta al sito dell'estinto villaggio medievale di Oliastreto
dove sorgono i ruderi (ma attualmente ne è in corso il restauro) dell'antica
parrocchiale di San Giorgio. La chiesa, attestata come esistente fin dalla
prima metà del XII secolo, è il frutto di una costruzione particolarmente
accurata. La sua notorietà è del resto comprovata dal fatto che ne trasse il
nome la contea di San Giorgio, comprendente gli attuali comuni di Tissi e di
Usini e concessa in feudo dagli Aragonesi ai Manca nel XVI secolo. La bella
fabbrica in conci di calcare chiaro di pezzatura uniforme ha subito nei
secoli danni rovinosi: al crollo della copertura si è aggiunta una trentina
d'anni fa quello della facciata.
3. Ossi: Chiesa di Sant'Antonio di
Briai.
Ritornati da San Giorgio sulla direttissima Sassari - Ittiri, ne percorriamo
un breve tratto a ritroso, uscendo allo svincolo di Tissi e percorrendo la
strada provinciale fino ai limiti dell'abitato di Ossi, dove svolteremo a
destra per Ittiri e Banari. Dopo una decina di chilometri, proprio in
corrispondenza dell'ampio slargo da cui si dirama il bivio per Florinas,
potremo fermarci a visitare la 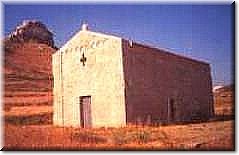 piccola
chiesa romanica di Sant'Antonio Abate, che sorge solitaria sul sito del
villaggio scomparso di Briai (o Briave, o Bere) di cui era forse la
parrocchiale. piccola
chiesa romanica di Sant'Antonio Abate, che sorge solitaria sul sito del
villaggio scomparso di Briai (o Briave, o Bere) di cui era forse la
parrocchiale.
Ossi: la chiesa di Sant’Antonio Abate sorge sul sito del villaggio
scomparso di Briai
Delle numerose chiesette romaniche
disseminate nel territorio di Ossi, quasi sempre, come in questo caso, a
presidio di estinti villaggi medievali, è questa la sola in buono stato di conservazione
ed agibile, anche grazie a una serie di successivi restauri che, risarcendone
le parti mancanti con materiale non originario, ne hanno almeno assicurato la
stabilità. La strada che abbiamo percorso, da Ossi a Sant'Antonio, sfiora
l'una dopo l'altra due chiese romaniche in rovina, Santa Margherita e San
Silverio (Santu Silvaru), mentre una terza, mancante di copertura, si trova
in località Noale. Costruita in conci di arenaria locale, presenta facciata e
fianchi semplicissimi, spogli, decorati soltanto da file di archetti pensili
che corrono lungo tutto il perimetro. La posizione panoramica in cui sorge si
trova proprio al confine col territorio comunale di Florinas, la cui
parrocchia ne mantiene, per ragioni storiche, la giurisdizione e ne conserva
la statua.
4. Banari:Chiesa di Santa Maria di Cea.
Dal crocevia sul quale sorge la chiesa di Sant'Antonio procediamo verso sud
lungo la provinciale per Banari, lasciando successivamente alla nostra destra
il bivio per Ittiri e alla nostra sinistra quello per Florinas: poco dopo
quest'ultimo incrocio, e immediatamente prima del ponte che scavalca il Rio
Mannu (si tratta del Rio Mannu di Porto Torres), scorgeremo sulla sinistra
della strada, biancheggiante nei suoi conci di calcare e adagiata nel verde
sul fondo delta  valle, la
bella chiesa romanica di Santa Maria di Cea, oggetto di un recente, dignitoso
restauro. valle, la
bella chiesa romanica di Santa Maria di Cea, oggetto di un recente, dignitoso
restauro.
La chiesa di Santa Maria di Cea, in territorio di Banari
La chiesa, datata al 1260 da
un'iscrizione apposta sulla facciata, dipendeva dal monastero vallombrosano
di San Michele di Salvenero ed è collegata a un romitorio tuttora in buono
stato di conservazione. Ma in questa sito sorgeva anche il villaggio
medievale di Cea (o Sea, o Seve), la cui esistenza è attestata dall'XI secolo
e che risulta già spopolato e scomparso alla fine del XVI. La chiesa, ad aula
mononavata absidata con copertura a capriate di legno, presenta una facciata
a tre arcate nella quale si apre un portale ingentilito da pseudocapitelli
fitomorfi. Nei dintorni dell'edificio sono in corso scavi archeologici
miranti a riportare alla luce i resti dell'antico villaggio.
5. Borutta: Abbazia di San Pietro di Sorres.
Attraversati l'uno dopo l'altro gli abitati di Banari, Siligo e Bessude,
raggiungiamo Thiesi e di qui, dopo aver percorso un breve tratto della
statale 131bis verso l'innesto della Carlo Felice, svoltiamo a sinistra per
Borutta: lungo la strada incontreremo la deviazione per San Pietro di Sorres,
una delle più belle chiese romaniche dell'isola che svetta alta dalla cima di
un colle calcareo sopra il piccolo paesello di Borutta (331 abitanti nel
1998). Oggi è l'abbazia di un monastero benedettino in piena attività, dotato
fra l'altro di un'importante biblioteca di circa 24000 volumi, ma per oltre
tre secoli (dal XII fino all''inizio del XVI) fu la cattedrale della
cittadina di Sorres, sede dell'omonima diocesi. La decadenza della città, di
cui non restano tracce, iniziò probabilmente nella seconda metà del XIV
secolo, quando gli Aragonesi, conquistata questa posizione elevata e
strategica, la fortificarono, facendone uno degli epicentri della loro lunga
lotta contro i Doria, una delle cui principali linee difensive è tuttora ben
attestata poco più a sud, lungo l'arco che congiunge Monteleone Rocca Doria a
Roccaforte (sopra l'attuale abitato di Giave) passando per Bonuighinu in
comune di Mara. La vita a Sorres dovette allora farsi impossibile e la
popolazione abbandonò rapidamente il villaggio, preceduta dal vescovo, che si
trasferì nel minuscolo borgo di Borutta, la cui modesta chiesa parrocchiale
ebbe per forse un secolo il titolo di cattedrale. San Pietro di Sorres
conserva ben evidenti i segni della sua antica dignità. La facciata, ornata
di archetti e di preziose tarsie rosa disposte a losanga, è ripartita da due
cornici orizzontali in tre ordini: i due inferiori sono in conci bianchi di
calcare, mentre quello superiore adotta il tipico motivo a fasce alternate di
trachite e calcare, ripreso lungo i fianchi e nell'abside. L'interno, a tre
navate divise da pilastri, è interamente voltato a crociera, cosa eccezionale
per quel periodo in Sardegna: vi si conservano un pulpito gotico, un altare
romanico, un sarcofago del vescovo Goffredo Benedettino e una statua lignea
di stile spagnolo, raffigurante una Madonna con Bambino. L'adiacente
convento, ricostruito sulle rovine dell'antica casa vescovile, è stato
edificato negli anni Cinquanta, risparmiando ben poco delle strutture
originarie.
6. Torralba: Chiesa di Nostra Signora di Cabu Abbas.
Ridiscesi da San Pietro di Sorres sulla provinciale, conviene ripercorrerne a
ritroso il tratto fino alla statale 131bis: qui svolteremo a sinistra, verso
la Carlo Felice, e, sottopassatala, procederemo seguendo le indicazioni per
il Nuraghe Santu Antine. Subito prima del nuraghe un sentiero sulla destra
conduce alla chiesa romanica di Nostra Signora, che sorge sul sito
dell'estinto villaggio medievale di Cabu Abbas e alla quale era annesso uno
dei più antichi conventi benedettini della Sardegna. Il toponimo di Cabu
Abbas (Capo delle Acque) sta a testimoniare la fertilità di questa piana
dalle antiche tradizioni agricole, intensamente frequentata fin dalla
preistoria, come attestano, oltre al vicino Nuraghe Santu Antine (uno dei più
imponenti dell'isola), gli altri numerosissimi che popolano in ogni direzione
la valle, non a caso ribattezzata Valle dei Nuraghi. La chiesa, realizzata in
conci bianchi di calcare con inserti scuri di trachite, risale al XIII
secolo. La facciata, molto semplice, è movimentata da sottili lesene
sormontate da una cornice di archetti pensili. Sul timpano spicca una curiosa
figura antropomorfa, databile forse al XVII secolo.
7. Bonorva: Chiesa di San Lorenzo di
Rebeccu.
La prossima meta del nostro itinerario costituisce un'eccezione
nell'ininterrotta sequenza di abitati estinti, dei quali le chiese
rappresentano in genere i soli edifici sopravvissuti all'abbandono. Il
villaggio medievale di Rebeccu, infatti, un tempo centro animato e di qualche
importanza (fu capoluogo della curatoria di Costaval nel giudicato di Torres),
poi decaduto rapidamente e spopolatosi, rimane tuttavia prodigiosamente
intatto, con le sue tortuose viuzze scavate nella roccia e le antiche
semplici abitazioni divenute oggi in gran parte case di villeggiatura.
 Bonorva:
la chiesa di San Lorenzo era la parrocchiale del villaggio di Rebeccu Bonorva:
la chiesa di San Lorenzo era la parrocchiale del villaggio di Rebeccu
Per raggiungerlo, procediamo da Cabu
Abbas lungo la provinciale per la stazione di Torralba e, superatala, sempre
diritto per la medesima strada fino a incontrare sulla destra una stradina
secondaria che piega in direzione sud-ovest per andare a confluire nella
provinciale Bonorva-Bono: qui a sinistra e, poco dopo, a destra al bivio per
Rebeccu.
La chiesa romanica di San Lorenzo,
probabilmente antica parrocchiale di Rebeccu, sorge a destra della strada,
leggermente appartata rispetto al villaggio che domina da una piccola altura.
La costruzione ad una navata chiusa da un'abside risale al XII secolo.
Presenta una bella facciata decorata da archetti pensili, in conci di calcare
chiaro ravvivati da inserti irregolari di trachite nera. La bicromia si fa
più ordinata nell'arco di scarico che sovrasta il portale. Parzialmente
smantellata nell'Ottocento, quando i materiali furono riutilizzati per la
costruzione di una nuova parrocchiale, la chiesa è stata ben restaurata di
recente (1982).
8. Bono: Chiesa di San Gavino di Lorthia.
Da Rebeccu ritorniamo sulla provinciale, dove svoltiamo a destra in direzione
di Bono: la strada prende gradualmente a salire verso i monti della Catena
del Goceano, addentrandosi in un paesaggio boscoso dalla vegetazione sempre
più fitta. Attraversiamo la frazione di Foresta Burgos e procediamo ancora
fino all'abitato di Bono: di qui scendiamo verso la valle del Tirso lungo la
provinciale per Bitti e, scavalcato il fiume, raggiungiamo dopo tre
chilometri il sito di un altro villaggio medievale estinto, quello di Lorthia
o Lorzia. Qui, nel breve spazio di poche centinaia di metri, sorgono ben
cinque chiese, dette appunto le Cinque Chiese del Campo, una sola delle
quali, la prima che s'incontra, risale all'epoca in cui il borgo era abitato.
La chiesetta romanica di San Gavino (Santu Baingiu), costruita nel XII
secolo, interamente in mattoni di cotto (caso non molto comune fra gli
edifici romanici sardi), era anzi la parrocchiale di Lorthia. Il rifacimento
della copertura ne ha un po' snaturato la facciata, mentre l'abside
restituisce intatte la spoglia semplicità della fabbrica e la calda tonalità
del materiale. Poco distante, in bella posizione elevata, sorge la chiesa di
Santa Restituta, la più imponente delle cinque. Le altre tre sono dedicate a
San Nicola (la più suggestiva, interamente intonacata di bianco), Santa
Barbara e Sant'Ambrogio. Da Lorthia si prosegue per la medesima strada fino a
incontrare, dopo una ventina di chilometri, la statale 389: qui a destra, per
raggiungere Nuoro in circa un quarto d'ora.
|

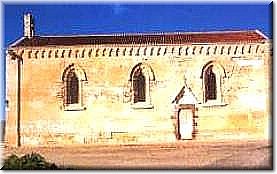
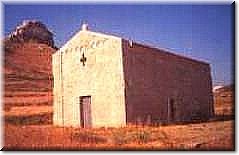

 Bonorva:
la chiesa di San Lorenzo era la parrocchiale del villaggio di Rebeccu
Bonorva:
la chiesa di San Lorenzo era la parrocchiale del villaggio di Rebeccu