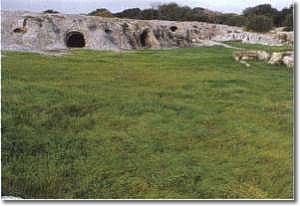|
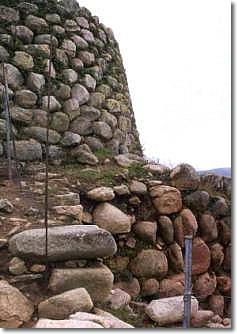 Pattada.
Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago
artificiale Pattada.
Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago
artificiale
Fra natura e
opera umana i monumenti della preistoria sarda si presentano agli occhi del
visitatore come un reame intermedio, che tiene dell'una e dell'altra in
eguale misura. Il semplice dato quantitativo, superiore ad ogni sforzo
d'immaginazione, da un'idea della quotidiana familiarità di rapporti che si
è venuta a stabilire nei millenni fra emergenze archeologiche e paesaggio. A
tutt'oggi, sulla base di censimenti inevitabilmente parziali, che vengono
arricchiti ogni anno da decine di nuove, a volte clamorose scoperte, sono
registrati con certezza in Sardegna circa 8000 nuraghi: uno ogni tre chilometri
quadrati o, se si preferisce, uno ogni duecento abitanti. Le domus dejanas,
sepolture ipogeiche con caratteri originali che le distinguono da altre
analoghe tombe diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo, sono, nella sola
provincia di Sassari, dove questa tipologia si concentra in modo quasi
esclusivo, circa 2000. A queste due grandi famiglie monumentali occorre poi
aggiungere le centinaia di tombe di giganti e le decine di dolmen e di
luoghi di culto nuragici, che tendono col progredire degli studi ad affermare
una presenza ben meno sporadica di quanto si ritenesse fino a pochi anni or
sono.
Poiché questi monumenti sono per la massima parte
dispersi per le campagne, arrampicati sui colli, scavati nella roccia, nascosti
nel folto della macchia, è facile arguire come un itinerario archeologico
si traduca sempre in Sardegna in un'esplorazione del territorio o in quella
che potremmo definire, ancor più che un'escursione, un'incursione nei
segreti della natura. Questo rapporto forte, quasi simbiotico, fra
archeologia e paesaggio si rende particolarmente manifesto nel caso dei nuraghi,
assurti a icona simbolica della Sardegna non tanto nel modo, tutto
storico-culturale, in cui le Piramidi lo sono dell'Egitto, quanto piuttosto
in quello, profondamente biologico, in cui i canguri lo sono dell'Australia:
come un endemismo della fauna o della vegetazione. Lo stesso discorso può
farsi del resto, e forse a maggior ragione, per Le domus de janas, cosi
profondamente legate alla terra, cosi ben nascoste con i loro tesori inaspettati
nelle cavità della roccia, così difficili da estrarre dai loro travestimenti
mimetici.
Il gruppo di
undici itinerari archeologici che segue è perciò prevalentemente organizzato,
a somiglianzà di quello degli itinerari dedicati al paesaggio, in un vasto
giro della provincia che, in nove successive tappe, tocca i punti di maggiore
interesse che s'incontrano via via lungo il cammino. Seguono due itinerari
di più approfondita trattazione tematica: il primo è dedicato ai dolmen, che
si concentrano in un'area relativamente ristretta del territorio e disegnano
il profilo di una tipologia architettonica molto ben definita; il secondo
infila invece in una lunga collana alcuni dei tesori lasciati in Sardegna
dalle popolazioni forestiere che, nel corso dei millenni, vi hanno
soggiornato per una breve stagione o, come i Romani, per alcuni secoli. Sono
testimonianze, in molti casi di eccezionale valore, che aggiungono ulteriore
interesse all'esplorazione archeologica di un'isola già insolitamente ricca
di monumenti preistorici.
|
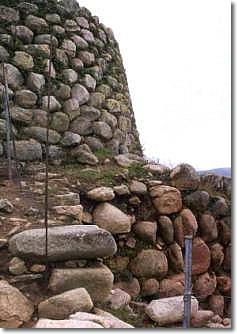 Pattada.
Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago
artificiale
Pattada.
Il nuraghe Lerno sorge oggi a poca distanza dalla riva dell'omonimo lago
artificiale