Da Alghero a Sassari
|
|
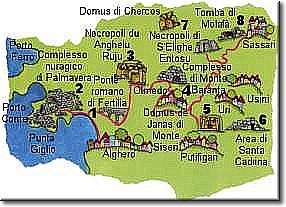
|
|
|
|
Distanza complessiva da percorrere
|
circa 75 Km
|
|
Tempo medio di percorrenza
|
circa 2 ore
|
|
Percorsi a piedi
|
circa 1 ora
|
|
Tempi di sosta e visita
|
circa 4 ore
|
|
Durata complessiva dell'itinerario
|
circa 7 ore
|
|
1. Alghero:
Ponte romano di Fertilia.
|
|
2. Alghero:
Complesso nuragico di Palmavera.
|
|
3.
Alghero: Necropoli di Anghelu Ruju.
|
|
4. Olmedo:
Complesso prenuragico di Mode Barante.
|
|
5. Putifigari:
Domus de janas di Monte Siero.
|
|
6. Uri:
Area archeologica di Santa Cedrina.
|
|
7. Usini:
Necropoli di S'Elighe Entosu e Domus a prospetto architettonico di Chercos.
|
|
8. Sassari: Tomba ipogeica di Molafà.
|
1. Alghero:
Ponte romano di Fertilia.
Partiti da
Alghero, si imbocca la strada litoranea in direzione nord e, tenendo sempre
il mare sulla propria sinistra, si costeggia il Lido, proseguendo fino a
raggiungere, dopo circa sei chilometri, la frazione di Fertilia. Qui,
attraversando lo Stagno di Calich, si possono ammirare sulla destra, molto
vicine, le tredici arcate residue (sulle ventiquattro originarie) del
poderoso ponte romano. Il ponte faceva parte della strada che, attraverso lo
Stagno di Calich, si dirigeva verso Porto Conte (Portus Nympharum) e quindi
alla stazione di Carbia, nelle vicinanze dell'attuale Alghero.
2. Alghero: Complesso nuragico di Palmavera.
A Fertilia ci si immette sulla strada statale 127 bis in direzione di Porto
Conte e se ne percorrono circa quattro chilometri, fino ad incontrare, sulla
destra, il 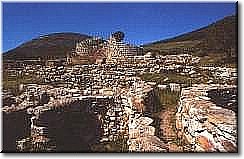 grande Complesso nuragico di Palmavera. grande Complesso nuragico di Palmavera.
Una veduta
d’insieme del complesso nuragico di Palmavera (Alghero)
Interessante
esempio di nuraghe complesso, il Nuraghe di Palmavera presenta due torri, di
cui quella centrale, più antica, risale al XV secolo a.C. (Età del Bronzo
medio). A questa, circa tre secoli più tardi (Età del Bronzo recente), venne
aggiunto un rifascio murario di forma ellittica con una torre a protezione
dell'ingresso, dando luogo a un cortile con due aperture, collocate una ad
est e l'altra a sud. Attorno al nuraghe esisteva il villaggio, tuttora in
fase di scavo e non completamente conosciuto nella sua estensione. Il
complesso è posto al centro di un territorio che comprende moltissimi altri
nuraghi, per lo più monotorre, alcuni dei quali di notevole interesse, che
orlavano le alture circostanti. Vari reperti (per lo più ceramiche e bronzi),
rinvenuti negli anni i Sessanta durante l'esplorazione e il restauro del
sito, sono custoditi attualmente nei musei archeologici di Sassari e di
Cagliari.
3. Alghero: Necropoli di Anghelu Ruju.
Visitato il Nuraghe Palmavera, si fa ritorno sulla 127 bis fino ad
oltrepassare Fertilia e, aggirando Alghero dall'interno, si raggiunge
l'incrocio con la provinciale per Porto Torres qui si svolta a sinistra e,
percorsi circa cinque chilometri, si accosta sulla sinistra per visitare la
necropoli a domus de janas di Anghelu Ruju che, con le sue 36 tombe, è la più
vasta della Sardegna.  Si presenta divisa sostanzialmente in due zone, una con meno
sepolture a nord-ovest e una più densa a sud-est. Si presenta divisa sostanzialmente in due zone, una con meno
sepolture a nord-ovest e una più densa a sud-est.
Alghero: la necropoli ipogeica di Anghelu Ruju
In loco è
esposta una pianta scolpita su una lastra marmorea, utile per identificare le
varie tombe. In particolare si segnala la tomba III, con un lungo dromos
(corridoio) d'ingresso e una serie di stanzette disposte a croce, che fanno
pensare a un disegno unitario realizzato in un unico momento. Vi sono ancora
camere scavate con forme geometriche nelle tombe XIX, XX bis, XXX. Alle
pareti della camera della tomba XX bis si possono notare corna di toro
stilizzate che compaiono anche in altri ipogei: sono simboli della forza
riproduttrice della natura. Le sepolture erano per lo più di cadaveri inumati,
spesso distesi su letti di pietre. La necropoli appartiene al periodo
(3500-2700 a.C.) della Cultura detta "di Ozieri", ma fu poi
riutilizzata in epoche preistoriche successive. I reperti d'interesse
archeologico estratti dalle tombe sono conservati in parte al Museo
archeologico di Cagliari, in parte al Museo Sanna di Sassari.
4. Olmedo: Complesso prenuragico di Mode Barante.
Si prosegue in direzione di Porto Torres e subito, sulla destra, si svolta in
una strada di penetrazione agraria che, costeggiando dapprima gli edifici
dell'azienda agricola I Piani e attraversando poi i vigneti della Tenuta
Sella e Mosca, sbuca qualche chilometro a nord-est sulla provinciale per
Olmedo: qui si svolta a destra, si supera l'abitato di Olmedo, si procede ancora
per poco più di un chilometro e mezzo per poi svoltare a sinistra in una
strada fiancheggiata dalle tubature della condotta d'irrigazione. Di questa
strada si percorreranno 1,2 chilometri, piegando quindi a destra in una
stradetta asfaltata (fuorché per i primi metri) che in un chilometro conduce
all'ingresso del sentiero pedonale (segnato da alcuni gradini) lungo il
quale, in circa dieci minuti di cammino, si sale alla cima del monte. Le
difficoltà di reperimento del sito e la fatica della ripida ascesa sono
compensate dal grande interesse archeologico del monumento e dalle
proporzioni impressionanti delle rovine. Il complesso risale alla cultura
eneolitica di Monte Clero (2400-2000 a.C.) e sorge in posizione suggestiva
sul margine dell'altipiano che domina la pianura tra la valle del Cuga e
Alghero. L'insediamento è composto da strutture a carattere civile, militare
e religioso, fra le quali spicca un recinto a ferro di cavallo che ricorda
nelle caratteristiche architettoniche i nuraghi a corridoio di epoca
posteriore. Il recinto, formato da due paramenti in blocchi di trachite
riempiti di pietrame, racchiude due corridoi con volta a piattabanda e un
cortile semicircolare. Completano l'insieme un circolo megalitico,
originariamente formato da lastre di pietra e menhir, e una ciclopica
muraglia difensiva lunga ben 97 metri, nei pressi della quale si notano i
resti di numerose capanne rettangolari a più ambienti. L'insediamento ha
precisi riferimenti con la muraglia megalitica di Monte Ossoni a Castelsardo e
ricorda da vicino analoghe tecniche costruttive di alcuni edifici preistorici
delta Francia meridionale.
5. Putifigari: Domus de janas di Monte Siseri.
Ritornati sulla provinciale, si svolta a sinistra, percorrendone il tratto
restante, di circa tre chilometri, fino alla sua confluenza nella statale 127
bis Alghero - Sassari. Qui si svolta nuovamente a sinistra, in direzione di
Sassari, e dopo qualcosa meno di cinque chilometri (in corrispondenza del
cartello segnaletico del km 21), a destra per Putifigari: ma, percorsi 250
metri circa, si piega a sinistra in uno sterrato, poi subito due volte
consecutive a destra così da sottopassare la strada percorsa in precedenza.
Avanti ancora per 250 metri, quindi a sinistra in uno sterrato che poco dopo
supera uno stretto ponte su un ruscello: dopo il ponte si tiene sempre la
sinistra, costeggiando la riva del fiume per circa un chilometro, quindi si
lascia l'auto e si prosegue a piedi lungo la riva per altri 600 metri circa.
Qui il fiume forma un'ampia ansa e sulla destra si nota una costruzione
all'interno delta quale si trova la Domus de janas di Monte Siseri. La
sepoltura, scavata in una collina di tufo trachitico di colore rosato, è
chiamata "Tomba dell'Architettura dipinta" o di
"S'Incantu" (della magia) perché i vani sono decorati da bei motivi
architettonici e naturalistici dipinti di rosso o di nero. la tomba è
costituita da un dromos (un corridoio), un'anticella, una cella di
disimpegno, notevole per la vastità e per il soffitto a doppio spiovente
scolpito e dipinto, e da due vani funerari più piccoli. All'esterno della
tomba un sistema di canalette scavate nella roccia preservava il sepolcro
dall'acqua piovana, mentre alcune coppelle e vaschette erano destinate al
rito funebre. Sono presenti in questa tomba molti degli elementi ornamentali
che i caratterizzano le domus de janas: le corna del toro, simbolo della
forza riproduttrice della natura, il motivo della falsaporta che doveva
consentire all'anima il passaggio nel mondo dei morti, la pittura rossa che, richiamando
il colore del sangue, simboleggiava la vita. La tomba di Monte Siseri si
trova a breve distanza dalle necropoli di Anghelu Ruju e di Santu Pedru,
entrambe in territorio di Alghero: l'addensarsi in questa zona di esempi di
domus de janas dipinte, con evidenti affinità stilistiche, lascia ipotizzare
l'esistenza di maestranze specializzate che avrebbero operato in un'area
compresa fra la Nurra di Alghero e il Meilogu (Mandra Antine di Thiesi). I
materiali rinvenuti appartengono alla cosiddetta "Cultura di
Ozieri" (Neolitico recente, 3500-2700 a.C.).
6. Uri: Area archeologica di Santa Cedrina.
Fatto ritorno alla statale 127 bis, si prosegue in direzione di Sassari fino
allo svincolo di Uri dove, proprio al centro del paese, visiteremo gli scavi
di Santa Cedrina. L'area si estende su una superficie di circa 2000 metri
quadrati ed è di proprietà del Comune, che ha già predisposto un progetto di
valorizzazione, con allestimento di un annesso centro di documentazione. Vi
si trova un nuraghe complesso (una torre centrale cui si affiancano altre due
torri), circondato da un vasto villaggio. Nel corridoio del nuraghe e nel
villaggio sono riconoscibili due pozzi, il primo dei quali a canna verticale.
Ma l'interesse del sito è dovuto soprattutto alla continuità di insediamenti
di cui reca testimonianza: vi sono infatti presenti strutture murarie
rettilinee, con almeno due ambienti conservati, di età romana. I rinvenimenti
di materiali coprono un periodo esteso dall'età nuragica a quella punica,
romana e bizantina.
7. Usini: Necropoli di S'Elighe Entosu e Domus a prospetto architettonico
di Chercos.
Da Uri procediamo lungo la statale 127 bis in direzione di Sassari e, dopo
poco più di quattro chilometri, un pò prima del bivio per Usini, svoltiamo a
sinistra, seguendo le indicazioni, per raggiungere la Necropoli di S'Elighe
Entosu: la strada, asfaltata, conduce dopo 700 metri ad un
abbeveratoio, dove si imboccherà uno sterrato in salita, lasciando l'auto
dopo circa 200 metri, dinanzi all'ingresso (a sinistra) di una
proprietà privata.

Usini,
necropoli S’Elighe Entosu: lo spettacolare interno della Tomba III
Percorse a
piedi poche decine di metri, si scenderà a destra lungo il costone roccioso nel
quale sono scavate alcune delle tombe (le altre sono ubicate nella parte più
alta della proprietà). La necropoli è composta da otto domus de janas. Di
particolare interesse la domus V, che conserva nella cella un focolare
circolare di pietra, scolpito nel pavimento, e la copertura a doppio
spiovente che riproduce la travatura di un tetto ligneo. Su uno dei lati
brevi, decorazione architettonica scolpita con elementi scalari che ricordano
le capanne dei vivi. Notevole anche la domus III, o delle Sette Stanze, con
lungo dromos, graffiti medievali sulla parete d'ingresso e sette cellette a
corona intorno alla camera principale. Nelle immediate vicinanze si trova
un'altra sepoltura di notevole interesse: per raggiungerla faremo a ritroso
la strada fino alla statale 127 e, percorsi 700 metri in direzione di Usini,
svolteremo a sinistra seguendo le indicazioni per la chiesa campestre di San
Giorgio di Oliastreto. Dopo 1,6 chilometri piegheremo a destra nella strada
vicinale Sa Longhera, non asfaltata, che seguiremo per 1,4 chilometri: quindi
a sinistra in uno sterrato e, dopo un altro chilometro, lasciata l'auto, ci
inoltreremo a piedi nella campagna, a destra della strada fino ad avvistare,
dopo 200 metri, la domus di Chercos, raggiungibile attraverso un ripido
sentiero in discesa. La tomba di Chercos, appartenente alla tipologia di domus
"a prospetto architettonico" rappresentata in tutto il Sassarese da
numerosi esemplari, è scavata in un costone calcareo entro una valle di
rilievo paesaggistico. La cella a pianta ovoidale conserva all'interno un
basso sedile  piano, mentre nella parete di fondo è ricavata una nicchietta
ogivale di fattura accurata. Di notevole interesse i numerosi graffiti e le
incisioni schematiche raffiguranti elementi vegetali all'interno della
nicchia, sulle pareti e sulla volta. piano, mentre nella parete di fondo è ricavata una nicchietta
ogivale di fattura accurata. Di notevole interesse i numerosi graffiti e le
incisioni schematiche raffiguranti elementi vegetali all'interno della
nicchia, sulle pareti e sulla volta.
Usini: Domus a prospetto architettonico di
Chercos: l’ingresso alla tomba dissimulato in parte dalla vegetazione.
8. Sassari:
Tomba ipogeica di Molafà.
Si prosegue per la statale 127 bis in direzione di Sassari e, dopo circa 6
chilometri, all'altezza del casello ferroviario di Molafà, si vede apparire
sulla destra della strada l'ultima meta del nostro itinerario: la Tomba
ipogeica di Molafà. Come la precedente domus di Chercos, anche questa di
Molafà è una tomba ipogeica di età nuragica, con fronte a stele scolpita e
ambiente interno pluricellulare. Architettonicamente si colloca a mezza via
fra le domus de janas (sepolture prenuragiche scavate nella roccia) e le
tombe di giganti (sepolture a galleria con fronte a stele, tipiche della
civiltà nuragica): rappresenta l'esempio più significativo di questa
particolare tipologia di sepoltura, definita "domus a prospetto
architettonico" e particolarmente mente diffusa nel Sassarese. Nei
pressi della tomba sorge l'omonimo nuraghe, monotorre.
|