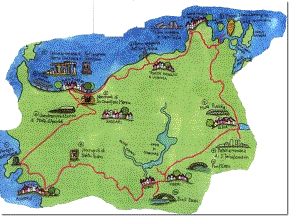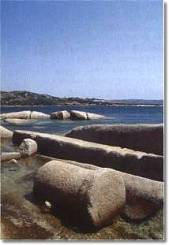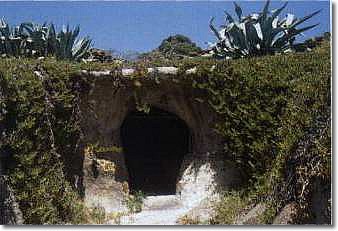I popoli venuti dal mare
Parte 2a |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
6. Trinità
d'Agultu e Vignola: Torre spagnola dell'Isola Rossa. Da un
popolo conquistatore ad un altro, ci spostiamo adesso con un balzo in avanti di
oltre un millennio lungo la strada costiera, da Porto Torres a Castelsardo e
di qui, lambendo i lunghi arenili di Valledoria e Badesi, fino al Borgo
dell'Isola Rossa, per visitare una delle più robuste testimonianze del
dominio politico-militare spagnolo, esercitato anche mediante il sistematico
controllo dei litorali. Qui, in verità, nel piccolo villaggio di pescatori
sorto fra le belle rocce di granito porfìrico dai colori rossastri, di fronte
alla piccola Isola Rossa che dista non più di 400 metri dalla linea di
costa, possiamo trovare un'ulteriore testimonianza delle fitte relazioni,
questa volta pacifiche, fra la Sardegna e l'esterno: il villaggio fu infatti
fondato, fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, da famiglie di
pescatori ponzesi che già da vari decenni avevano preso a frequentare
stagionalmente questo pescosissimo tratto di mare, rinomato, oltre che per
le aragoste e per i pesci pregiati, per l'abbondanza di corallo. Ci troviamo
ormai in Gallura, e tutta la Gallura costiera ha conosciuto, dalla fine del
Medioevo fino a tempi molto recenti, un destino di spopolamento e di
abbandono dovuto principalmente a due cause: la malaria e le incursioni
piratesche. Questo spiega, da una parte, l'assenza pressoché totale di
insediamenti urbani storici sul litorale (nei 65 chilometri da Castelsardo
a Santa Teresa è questo il solo che s'incontra), dall'altra il fatto che le
attività di navigazione e di pesca, completamente dismesse dai sardi, siano
diventate terreno di conquista di genti venute ancora una volta da fuori,
principalmente liguri e, appunto, ponzesi. Ma questo
spiega anche la presenza, in questo tratto di costa solitario e selvaggio,
battuto dai venti, di una torre di tale imponenza architettonica, per non
dire monumentale. Di torri aragonesi e spagnole è punteggiato l'intero
litorale della Sardegna e un itinerario che volesse toccarle tutte, l'una dopo
l'altra, risulterebbe lungo e faticoso ma certamente spettacolare come
pochi, perché permetterebbe di prendere visione di ogni centimetro di costa,
di ogni scoglio e di ogni increspatura del mare. Infatti questo sistema di
torri (integrato da quelle preesistenti, di costruzione genovese e pisana)
era concepito in modo che l'angolo ottico di ciascuna si sovrapponesse in parte
a quello delle due contigue, con le quali del resto la torre era in diretta
relazione visiva. Cosi non c'era tratto di mare che potesse sottrarsi al
controllo (come accade invece oggi in certe zone d'ombra dei radar) e la
guardia che avvistava una nave sospetta poteva comunicare la notizia con un
semplice gesto alle due guardie delle torri vicine, e ciascuna di queste due
ad un'altra, con una fulminea propagazione dell'allarme. Questa torre
dell'Isola Rossa, in particolare, appare più maestosa e di architettura più
accurata di altre perché il piccolo porto naturale del quale sta a vedetta
aveva un'importanza strategica non ordinaria: era infatti (ed è tuttora) uno
dei pochi approdi agevoli su un arco di svariate decine di miglia e per
questa ragione era il punto di sbarco prediletto da pirati e contrabbandieri.
Soprattutto contro le attività di questi ultimi, che prosperavano sui
traffici dalla vicina Corsica, fu eretta e fortificata la torre: a difesa,
si potrebbe ben dire, più che del territorio sardo, dell'erario spagnolo. 7. Santa
Teresa Gallura: Cave romane di Capo Testa. Torniamo
adesso ai Romani e, proseguendo per la strada Litoranea il cui tracciato
corrisponde in gran parte a quello della via da Turris a Olbia di età
imperiale, ci trasferiamo dall'Isola Rossa a Santa Teresa, il cui sito
potrebbe forse coincidere, come già si è detto, con quello della romana
Tibula. In ogni
caso i Romani ebbero insediamenti e interessi in questa zona, in particolar
modo a Capo Testa, spettacolare promontorio dalla forma tondeggiante
collegato alla terraferma da un istmo sottile, e celebre per le sue
biancheggianti rocce di granito, ora svettanti in aspri pinnacoli aguzzi ora
invece ammassate l'una all'altra in lisce sculture marmoree. Fu appunto
questo magnifico marmo ad attrarre a Capo Testa i Romani, che vi ebbero
importanti cave di granito, certamente attive per molti secoli. Nella parte nord-occidentale
del promontorio sono ancora ben visibili i resti di queste antiche cave. Ciò
che affiora dall'acqua delle numerose calette documenta una raffinata tecnica
di estrazione e di lavorazione della pietra. Santa Teresa Gallura: le cave romane di Capo Testa
Si possono
vedere grandi blocchi appena staccati, colonne semilavorate ed anche elementi
architettonici già lavorati sul posto prima di essere esportati. In località
Li Petri Taddati (cioè "le pietre tagliate") è documentato su una
roccia il procedimento adottato per l'estrazione: lungo la linea di
frattura della pietra si praticavano piccoli fori nei quali venivano inseriti
cunei di metallo o di legno. Le cave furono riutilizzate in età medievale,
nel periodo della dominazione pisana, e fornirono materiali per la costruzione
del Battistero e del Duomo di Pisa. La leggenda vuole che il granito di Capo
Testa sia servito anche, in età romana, per le colonne del Pantheon. Si tratta
appunto di una leggenda, forse falsa, ma sicuramente non priva di
fondamento: il marmo estratto qui veniva trasportato a Roma e si trasformò
senza dubbio in palazzi, terme, templi. Scogli che, dall'altra parte del
mare, diventavano edifìci. 8. La
Maddalena: Museo archeologico navale Nino Lamboglia. Sempre
sulle tracce dei Romani, lasciamo Santa Teresa per la vicina Palau e di qui
ci imbarchiamo sul traghetto che, solcando uno dei tratti di mare più belli
del Mediterraneo, ci conduce all'Isola della Maddalena. Un mare stupendo,
quello dell'arcipelago, ma anche insidioso: per la forza e il capriccio dei
venti, per l'ardua navigabilità degli stretti canali che separano un'isola
dall'altra, per le innumerevoli secche di cui è disseminato. Non si contano i
naufragi che sono avvenuti in queste acque dalla trasparenza di vetro. Di
uno di questi naufragi reca una testimonianza davvero suggestiva il museo
intitolato a Nino Lamboglia, uno dei pionieri dell'archeologia subacquea nel
nostro paese.
La Maddalena: in una sala del Museo archeologico navale Nino Lamboglia è ricostruito lo stivaggio delle anfore vinarie nella nave da carico romana naufragata al largo dell'isola di Spargi nel II secolo a.C. Il museo è
infatti incentrato sul relitto di una nave romana naufragata verso il 120
a.C. presso risola di Spargi e recuperato una ventina d'anni fa. Nella prima
sala è stato ricostruito un settore dello scafo, al cui interno sono state
disposte, secondo il metodo di stivaggio dei Romani, le numerose anfore
vinarie recuperate. Nella seconda sala sono esposti gli oggetti ritrovati a
bordo, tra cui uno scandaglio e cinque ancore di piombo. Dunque già in epoca
tardo-repubblicana, quando la Sardegna era sotto il pieno controllo romano da
circa un secolo (ma con focolai di rivolta nell'interno che si faticò parecchio
a domare), il traffico commerciale tra l'isola e il continente era già
intenso e, dobbiamo presumere, regolare. La nave trasportava in Sardegna
vino prodotto nella penisola, come dimostrano le anfore vinarie di
produzione italica. L'isola invece esportava, fra le derrate agricole,
prevalentemente grano: tutte le terre più fertili furono sistematicamente
organizzate dai colonizzatori per questa produzione intensiva. D'altro canto
in Sardegna i Romani avevano trovato una viticoltura già diffusa e ben
organizzata dai loro predecessori: alcuni studiosi ritengono che i Fenici,
tra i massimi enologi dell'antichità, avessero impiantato vigneti e
importato vitigni (fra i quali probabilmente la Vernaccia e il Nuragus)
nelle zone retrostanti i loro insediamenti costieri, cioè soprattutto nella
parte sud-occidentale dell'isola, e i Cartaginesi avevano poi valorizzato
l'esistente ed esteso la produzione ad altre regioni. I Romani, da quegli
abili e lungimiranti amministratori ecumenici che furono sempre, sfruttarono
presumibimente, col tempo, anche questa risorsa preziosa: ma senza eccesso,
badando bene ad evitare sovraproduzioni che avrebbero provocato contraccolpi
sul mercato continentale. Proprio la Vernaccia, a dispetto delle sue origini
più antiche, serba nel suo nome una traccia dell'apprezzamento romano:
deriva infatti con ogni probabilità da vernaccia. Come dire: prodotto Locale. 9. Olbia: Mura puniche. Lasciamo La
Maddalena e, fatto ritorno a Palau, raggiungiamo Olbia (strada statale 125,
passando per Arzachena) per fare la conoscenza dell'ultimo grande popolo
forestiero di cui non abbiamo ancora individuato le tracce. Olbia, a
dispetto dell'etimologia probabilmente greca del nome (Olbìa: la felice) e
della tradizione che la vuole fondata dai Focesi, cioè dai coloni greci
dell'attuale Marsiglia, è una città portuale che deve la sua originaria
struttura urbana alla fondazione punica nel IV secolo a.C. (anche se va
ricordato che recenti scavi hanno restituito ceramiche greco-orientali del VI
secolo). I Cartaginesi a quell'epoca controllavano l'intera isola e la minaccia
romana era ancora ben lontana dal rendersi manifesta (la conquista romana
avvenne in effetti dopo oltre un secolo, nel 238 a.C.). Tuttavia
l'insediamento urbano di Olbia, al di là dell'ottima posizione del porto e
della sua magnifica protezione naturale, aveva certamente, oltre alle
finalità mercantili, scopi strategici e di controllo territoriale su una zona
fino ad allora scarsamente presidiata. Della città punica di Olbia ci sono
noti numerosi resti dell'abitato, delle necropoli, delle installazioni portuali
e, caso raro in Sardegna, della cinta muraria, della quale è stato possibile
ipotizzare il circuito originario. Purtroppo quasi nulla di questi resti è
attualmente visibile. Della cinta muraria si possono osservare, tra via
Torino e via Acquedotto, in una piccola area verde, due cortine di grandi
blocchi bugnati di granito perfettamente squadrati, che definiscono un ambiente
a pianta rettangolare separato all'interno in vani minori da tratti di
muratura di pietre più piccole. L'apertura fra le due cortine corrisponde a
una delle antiche porte della città. A pochi metri di distanza, in direzione
nord, sono visibili, attraverso il cancello di una proprietà privata, gli
imponenti resti granitici di una delle torri a pianta rettangolare della
cinta muraria, in opera quadrata. Il tratto di mura che si conserva in via
Porto Romano, all'interno della farmacia Lupacciolu, è invece di età romana
imperiale: ma sotto la pavimentazione dell'adiacente piazza Regina
Margherita sono stati scavati i resti di una cisterna punica. Di particolare
interesse sono le rovine nel giardino privato della Villa Tamponi, nelle
vicinanze del porto: la muratura, ad andamento rettilineo, è costituita da
blocchi squadrati messi in opera a secco. In epoca relativamente recente,
nel prospetto della muratura furono cementati numerosi frammenti ceramici di
età punica e romana, certo provenienti dal terreno circostante. Un ultimo
tratto di mura si conserva, in parte sotto il livello dell'acqua, presso il
Porto Vecchio, in località Su Cuguttu: le due strutture visibili, a pianta
quadrangolare, sono forse i resti di due torri del circuito. 10. Olbia: Fattoria romana di
S'Imbalconadu. Dopo la
conquista romana, la città di Olbia prosperò per svariati secoli non soltanto
grazie ai traffici del porto, ma anche grazie alla fertilità della sua
campagna, subito alle spalle della costa. Qui come in tutte le pianure
piccole e grandi dell'isola (nel Nord Sardegna la Nurra, il Campo di Ozieri,
il Campu Giavesu, vaste aree della Romangia e dell'Anglona) i Romani
organizzarono un'agricoltura intensiva mirante soprattutto alla produzione
di grano e, nelle zone collinari, di vino. Grazie a un sapiente governo
delle acque, in effetti, queste regioni, fertili e irrigue ma nella maggior parte
dei casi malariche, conobbero nei secoli della dominazione romana una
prosperità e una popolosità inusitate: basti pensare che Olbia e tutto il suo
territorio, immediatamente dopo la caduta dell'impero, andarono incontro a
uno spopolamento totale, destinato a durare per oltre un millennio. In linea
generale non è azzardato affermare che tutte le terre malari-che della
Sardegna, prima delle grandi bonifiche del XX secolo, furono coltivate e
rese abitabili in modo stabile esclusivamente sotto il dominio romano. Qui
in particolare, nella zona di Olbia, si insediarono in età imperiale i grandi
latifondi delle più potenti famiglie di Roma: segno esplicito più di ogni
altro dell'elevata redditività delle terre. Un esempio piuttosto precoce di
fattoria romana, risalente al II secolo a.C. (dunque ancora all'età
repubblicana), è venuto recentemente alla luce pochi chilometri a sud di
Olbia, lungo la strada provinciale per Loiri: è visibile (e visitabile) sul
margine destro della strada, subito dopo il ponte sul fiume Padrogiano. Il
complesso produttivo, ubicato sulla sommità di una lieve altura, a 12 metri
sul livello del mare, è realizzato in pietre granitiche legate con malta di
fango, sulle quali si impostano gli alzati in mattoni. Della struttura, la
cui lunghezza originaria era di oltre 30 metri, si conserva un'ampia corte
che racchiude un isolato di quasi 9 metri di lato, forse una casa-torre di
almeno due piani che ospitava la dimora del conduttore della fattoria e
della sua famiglia, oltre a numerosi altri ambienti destinati alle attività
produttive, con vasche e cisterne. In alcuni vani sono stati identificati
gli impianti per la panificazione. Nella tenuta veniva probabilmente
praticata la coltura della vite. 11. Ozieri:
Pont’Ezzu. Se, dalla
provinciale per Loiri, risaliamo qualche chilometro a nord per imboccare la
statale 199 e ne percorriamo un lungo tratto in direzione di Oschiri e
Ozieri, potremo dire di aver seguito per alcune decine di miglia il tracciato
di un'altra strada romana di vitale importanza. Si è già visto infatti,
all'inizio del nostro itinerario, che la principale arteria del sistema
viario romano, la "a Turre Karales", si snodava su un tracciato in
gran parte simile a quello della Carlo Felice: da questa strada, nei pressi
di Mores (probabilmente coincidente con la romana Hafa), più o meno nello
stesso punto in cui prende origine l'attuale statale 128bis, si staccava
anche allora la diramazione per Olbia che, tagliando da sud-ovest a nord-est
il Campo di Chilivani, scavalcava il Rio Mannu circa tre chilometri a
nord-ovest di Ozieri per puntare quindi quasi in linea retta verso Olbia
lungo un percorso assai simile a quello della statale 199 di oggi. Questa
strada, dunque, ci porta senza alcuna difficoltà nelle immediate vicinanze
della prossima tappa dell'itinerario, costituita appunto dal monumentale
ponte romano che superava il Rio Mannu quasi al centro della piana di Ozieri:
per raggiungerlo non dovremo far altro che seguire la statale 199 fino alla
sua Il Pont’Ezzu di Ozieri Questo
nome, Pont'Ezzu, che significa semplicemente "ponte vecchio” connota
con estrema sobrietà la maggior parte dei ponti d'impianto romano esistenti
nel Nord Sardegna: uno, non lontano di qui, fra Mores e Ittireddu, sarà la
prossima tappa del nostro itinerario; un altro (vedi Itinerario 19) scavalca
il Tirso proprio al confine fra le Province di Sassari e Nuoro; di un terzo
(vedi Itinerario 12) restano i ruderi nei pressi del Coghinas in territorio
di Bortigiadas. Quello di Ozieri è, fra tutti, di gran lunga il più imponente
e monumentale. Costruito in età imperiale (I-III secolo d.C.), testimonia
della centralità di questa pianura nell'economia e nei traffici commerciali
del tempo. Il ponte, con paramento murario in opera quadrata in calcare,
presenta sei arcate con raggio di dimensione decrescente a partire da quella
centrale. La sua lunghezza totale è di 80 metri. 12. Mores-Ittireddu: Pont’Ezzu. Qualche
chilometro più ad ovest, al confine fra i territori comunali di Ittireddu e
di Mores, un altro ponte romano, di dimensioni decisamente meno imponenti,
scavalca lo stesso Rio Mannu in un tratto in cui il fiume, che poco più a
valle riceve alcuni dei suoi principali affluenti, ha una portata d'acqua e
un'ampiezza dell'alveo assai più modeste. Lo si può raggiungere dall'abitato
di Ittireddu (da Ozieri lungo la statale 128bis per Mores, quindi a sinistra
nella provinciale per Bono), imboccando una stradina che porta alla chiesa
di San Giacomo e seguendo poi le indicazioni per il ponte. La costruzione è
realizzata in pietra basaltica e tufo bianco alla base. Delle tre arcate
originarie ne restano in piedi due, che hanno raggi di lunghezza diversa.
L'ubicazione del ponte, pochi chilometri più a sud dell'attuale statale
128bis, ci permette di ricostruire ancor meglio il tracciato della
diramazione per 0lbia, che evidentemente si staccava dalla "a Turre
Karales" quasi in coincidenza con lo svincolo attuale. 13. Alghero: Necropoli di Santu
Pedru. L'ultima
tappa dell'itinerario ci riporta indietro sia nello spazio (per far ritorno
ad Alghero di dove siamo partiti) sia nel tempo, verso quegli "zingari
della preistoria" di cui già abbiamo fatto la conoscenza quasi
all'inizio del viaggio, nella necropoli di Su Crucifìssu Mannu presso Porto
Torres. Da Mores raggiungiamo l'innesto della Carlo Felice, ne percorriamo
un breve tratto in direzione di Cagliari, ne usciamo allo svincolo per
Thiesi e procediamo lungo la statale 131bis, attraverso Thiesi e Ittiri, fino
al bivio della cantoniera di Scala Cavalli: qui ci immettiamo nella statale
127bis in direzione di Alghero e, dopo circa tre chilometri, poche centinaia
di metri oltre la pietra miliare del km 24, troviamo sulla destra della
strada la necropoli di Santu Pedru, Alghero: necropoli di
Santu Pedru Fra le
numerose tombe presenti nel sito, quella di maggiore interesse, sia in
assoluto sia in rapporto al tema del nostro itinerario, è la tomba I,
chiamata anche "Tomba dei vasi tetrapodi" per la grande quantità di
materiali ceramici di questo tipo che vi furono rinvenuti (ora esposti al
Museo Sanna di Sassari). Questa domus fornì, grazie all'abbondanza di
reperti e alle condizioni di perfetta integrità in cui venne alla luce, la
prima sequenza stratigrafica affidabile della preistoria sarda, permettendo
tra l'altro di confermare la massiccia presenza, in un periodo databile
approssimativamente appena a monte del 2000 a.c., di quelle genti del Vaso Campaniforme di cui si è
detto in precedenza. I dati raccolti a Santu Pedru e in altre necropoli
vicine (come quella di Anghelu Ruju, sempre in territorio di Alghero, lungo
la statale 291 per Sassari) confermano che queste popolazioni furono accolte
e assimilate, certo anche grazie alle loro qualità di abili artigiani (vasai
e metallurghi), all'interno delle comunità locali di Cultura Ozieri, tanto
da trovare sepoltura nelle stesse domus de janas, dove i resti di questi
brachicefali, facilmente distinguibili da quelli dei dolicocefali di origine
mediterranea, si trovano circondati dai loro corredi funerari, costituiti
dagli oggetti che li rendono inconfondibili: il tipico bicchiere a campana, i
vasi a tre piedi, il brassard di pietra ed osso utilizzato come guardamano
dagli arcieri. Dalla necropoli di Santu Pedru, ultima tappa del nostro
viaggio fra i popoli venuti dal mare, si rientra da Alghero, lungo la
statale 127bis, in una decina di minuti. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||