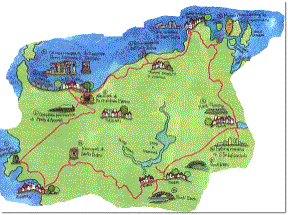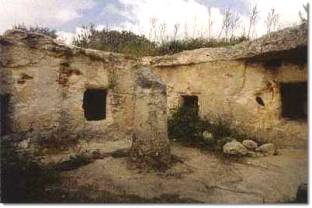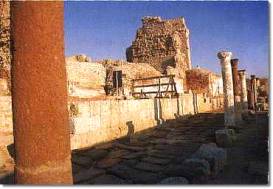I popoli venuti dal mare
Parte 1a |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Il rapporto
di un'isola col mare che la circonda è sempre ambivalente: il mare protegge
e minaccia, allontana e avvicina, imprigiona nel conosciuto e si spalanca
sull'ignoto. Lo si ama e lo si teme, lo si rispetta e lo si maledice. Dal mare
viene il forestiero, che può portare a suo capriccio la morte o la vita. Nel
caso della Sardegna questo destino comune ad ogni isola è stato esaltato in
entrambe le direzioni (il mare come difesa, il mare come minaccia) dalla
particolare posizione geografica: lontana più di ogni altra isola del
Mediterraneo dalle coste del continente, la Sardegna occupa però in questo
mare un posto così centrale che, fin dalle epoche più remote, non c'è stata
nave che non l'abbia incontrata, deliberatamente o per caso, dinanzi alla sua
prua. Parlare di "isolamento" nel caso della Sardegna è dunque
tanto etimologicamente appropriato quanto storicamente semplicistico. È un
isolamento che si spezza dì continuo, che si apre senza sosta a nuove
intrusioni, modificando di generazione in generazione l'identità culturale e
perfino genetica della gente isolana. Questo itinerario vuole proporre,
attraverso un ampio giro nel territorio del Nord Sardegna cui corrisponde,
nel tempo, un viaggio di circa quattro millenni, un campionario esemplare di
popoli che hanno lasciato nell'isola solide tracce del proprio passaggio. Si
va dai visitatori pacifici della preistoria, mossi chi dal caso chi dal
talento a intrecciare rapporti culturali e commerciali con gli indigeni, ad
autentici professionisti della navigazione e dello scambio come i Fenici,
entrati in importante relazione mercantile con i Nuragici, fino ai popoli
conquistatori, i Cartaginesi, i Romani, gli Spagnoli. Ciascuno di questi
visitatori, più o meno graditi, ha contribuito a costruire, strato per strato
e spesso a dispetto di se stesso e degli ospiti, l'identità complessa e
multiforme della Sardegna moderna. Nessuna storia, a conti fatti, può essere
isolata dalle altre: tanto meno quella di un'isola. 1. Alghero: Nuraghe
Sant'Imbenia. L'itinerario,
disteso su due giornate di viaggio con pernottamento alla Maddalena, è
immaginato con partenza e rientro ad Alghero, città che si trova al centro
di un territorio senza dubbio privilegiato dal punto di vista delle relazioni
della Sardegna con l'esterno. Al di là della sua realtà emblematica di
enclave catalana in terra sarda, capace di salvaguardare la sua diversità e
la sua specificità locale per oltre sei secoli, Alghero, la sua costa e il
suo immediato entroterra significano anche molte altre cose: un porto naturale
straordinariamente felice come quello di Porto Conte (il Nympharum Portus dei
Romani), una fertile campagna, una zona mineraria sfruttata non solo
nell'antichità ma fin dalla preistoria e, per quanto riguarda i Fenici (primo
popolo "alieno" del nostro piccolo viaggio), il fatto di aprirsi
sulla loro costa prediletta, quella occidentale, lungo la quale si
allineavano gran parte dei loro principali insediamenti litoranei: Sulci,
nell'isola di Sant'Antioco, Tharros e Othoca nell'Oristanese. Partiamo dunque
da Alghero in direziono di Fertilia e Porto Conte, e di qui proseguiamo
lungo la strada litoranea per Capo Caccia: circa quattro chilometri dopo
Porto Conte, quasi al limite occidentale della baia, incontriamo sulla sinistra
della strada il vasto insediamento nuragico di Sant'Imbenia (si può notare di
sfuggita che, nelle immediate vicinanze del sito, è stata portata alla luce
una grande villa d'ozio d'età romana imperiale, con strutture termali,
mosaici e vari ambienti dipinti). Il complesso nuragico è stato sottoposto a
scavi sistematici solo a partire dai primi anni 80, benché l'esistenza di un
nuraghe in questo sito fosse nota fin dagli inizi del secolo, ed ha
restituito materiali d'interesse scientifico fuor del comune: in particolare
ceramiche fenicie e greche, comprendenti fra l'altro un'anfora fenicia piena
di lingotti di rame. Sulla base di questi reperti è stato possibile
ipotizzare l'esistenza sul luogo di una sorta di emporion nuragico
frequentato dai mercanti fenici in cerca soprattutto di metalli. Questi
scambi, regolari e piuttosto intensi, dovrebbero risalire all'Età del Ferro,
tra la fine del IX secolo a.C. e l'inizio delI'VIII: un'epoca decisamente
avanzata per la civiltà nuragica e per la vita stessa del villaggio di
Sant'Imbenia, le cui tracce più antiche sono databili al Bronzo medio
(1600-1300 a.C.). Ma la persistenza delle popolazioni nuragiche e delle loro
strutture urbane ben addentro l'età storica e la loro interrelazione con i
Fenici prima, con i Punici e i Romani poi sono comprovate da non poche
testimonianze convergenti. Dalla stessa area, ricchissima di nuraghi, in cui
sorge il complesso di Sant'Imbenia, e precisamente dal Nuraghe Flumenelongu,
proviene del resto un bronzetto che costituisce la traccia più antica della
presenza fenicia nella Sardegna nord-occidentale. 2. Sassari: Complesso
preistorico di Monte d'Accoddi. Lasciando
ora momentaneamente la zona di Alghero, cui faremo ritorno alla fine dell'itinerario,
ma restando sempre all'interno della fertile Nurra, regione più ricca di ogni
altra di testimonianze "straniere", ci trasferiamo adesso nella
campagna di Sassari dove, in vista ormai del mare di Porto Torres e di
Platamona, sorge quella che, fra le innumerevoli emergenze preistoriche
della Sardegna, è forse la più sorprendente e la più difficile da decifrare.
Dalla strada Porto Conte-Capo
Caccia, attraverso la provinciale per Santa Maria la Palma e La statale 291,
raggiungiamo la 131 Carlo Felice alla periferia di Sassari e la imbocchiamo
in direzione di Porto Torres, percorrendone circa 11 chilometri, fino al bivio
per Bancali: qui dovremo invertire la marcia, puntando di nuovo verso
Sassari, e dopo circa un chilometro svoltare a destra nella piccola strada
asfaltata, ben segnalata da un cartello turistico, che conduce al Monte
d'Accoddi. Questo straordinario monumento archeologico, venuto alla luce un
po' casualmente negli anni 50, costituisce un unicum non solo in Sardegna, ma
in tutto il Mediterraneo occidentale. Ciò che lo caratterizza è infatti un
grande altare a terrapieno che, per il tipo di architettura e di concezione
scenografica, può essere paragonato solo alle ziqqurat mesopotamiche. Al momento
dello scavo l'altare si presentava come una collinetta artificiale,
dell'altezza di circa 8 metri, circondata da una muratura di contenimento
di forma quadrangolare, con una rampa d'accesso, priva di gradini, della
lunghezza di ben 75 metri. Intorno all'altare venne parzialmente alla luce
un villaggio di capanne rettangolari, che per la maggior parte si ritiene
fossero destinate al soggiorno temporaneo dei pellegrini, mentre alcune,
dall'aspetto più solido e stabile, appartenevano forse ai custodi del tempio
e alle loro famiglie. Ai piedi dell'altare, a sinistra, fu inoltre rinvenuto
un menhir rovesciato (ora ricollocato nella sua posizione originaria) alto
4,4 metri e, sulla destra, due
grandi lastre di pietra, una delle
quali del peso di oltre 6
tonnellate, che sono state
interpretate come tavole sacrificali. La grande pietra sferoidale che si i trova ora nelle vicinanze
del monumento fu invece rinvenuta 300 metri più a ovest, non lontano da
altri due menhir. Oggi il monumento
è stato restaurato e ricostruito,
non senza qualche forzatura (come quella appena citata) e anacronismo (il
menhir in posizione eretta, ad esempio, non appartiene alla stessa fase di
utilizzazione dell'altare, ma ad una di svariati secoli precedente), e il
suo suggestivo, impressionante impatto visivo è alquanto avvilito dalle
strutture in tubi metallici che lo circondano. Rimane tuttavia uno dei siti
archeologici più affascinanti dell'isola e solleva interrogativi solo in
parte risolti sulla sua origine. Si può affermare con una certa sicurezza che
l'altare fu costruito alla fine del Neolitico recente (2700 a.C. circa),
sovrapponendosi a un precedente insediamento di Cultura Ozieri, del quale
restano nella zona molteplici tracce: oltre al menhir in sito e ai materiali
emersi dagli scavi, una necropoli a domus de janas nelle immediate vicinanze
dell'altare (alle sue spalle) ed un'altra, quella di Ponte Secco, lungo il
margine della 131, a non più di 500 metri dall'imbocco della strada che porta
a Monte d'Accoddi. Si è dunque in presenza di un evidente apporto
vicino-orientale, o di mediazione egea, in un'area già intensamente
frequentata dalle popolazioni prenuragiche. Come questo culto orientale sia
approdato in Sardegna non siamo in grado di dire con certezza, ma l'ipotesi
più attendibile è senza dubbio quella di un gruppo di viaggiatori sbarcati,
forse casualmente, sulla costa del golfo e penetrati in questa campagna generosa
in cui le condizioni climatiche e le potenzialità produttive non erano poi
troppo radicalmente diverse da quelle conosciute in quell'area fertilissima,
fra il Tigri e l'Eufrate, in cui ebbero origine questi modelli di tempio e
dove fiorirono le grandi civiltà fluviali del Vicino Oriente. Il modello del
tempio-ziqqurat fu dunque importato a Monte d'Accoddi, probabilmente accolto
dalle popolazioni locali insieme con i culti e i riti che vi si
accompagnavano e che si perpetuarono lungo un arco di dieci, forse quindici
generazioni (l'altare fu ampliato nella cosiddetta "fase di
Abealzu" - 2500-2400 a.C. - e utilizzato fino agli albori dell'Età del
Bronzo, cioè fino al 1800 a.C. circa). Un successo relativo, dunque: localmente
solido, ma incapace dì espandersi nel territorio. 3. Porto Torres: Necropoli
di Su Crucifissu Mannu. Invertita nuovamente
la marcia al primo bivio, ritorniamo verso Porto Torres lungo la 131 Carlo
Felice e, al km 224, svoltiamo a destra in uno sterrato che in circa 500
metri conduce all'interessante sito preistorico di Su Crucifissu Mannu, la
più importante fra le innumerevoli necropoli a domus de janas che si Porto
Torres: la necropoli ipogeca di Su Crucifissu Mannu Sparse su un
tavolato calcareo pianeggiante vi sono oltre venti tombe, prevalentemente del
tipo a pozzetto, ma alcune anche a dromos, precedute cioè da un lungo
corridoio d'accesso. Di particolare interesse la tomba XVI, nel settore
sud-occidentale della necropoli, che al momento della scoperta (avvenuta
casualmente negli anni 50) si presentava ancora chiusa dall'apposita lastra
di pietra e dunque intatta, il che ha consentito, oltre al reperimento di
abbondante materiale fìttile, una perfetta ricostruzione della
sovrapposizione degli strati. In questa e in altre tombe (ad esempio la III e
la XV) è venuta alla luce una notevole quantità di materiale, sia ceramico
sia litico, attribuibile con certezza alle cosiddette genti del Vaso
Campaniforme (o, con termine inglese, del Beaker), un affascinante esempio di
popolo nomade della preistoria che prende nome dal particolare oggetto di
cui, si può ben dire, ha riempito l'intera Europa: un bicchiere di ceramica
dalla caratteristica ed elegante forma a campana (più largo cioè alla base e
alla bocca, svasato invece nella parte centrale), decorato con motivi
geometrici disposti a fasce orizzontali. Altri oggetti tipici di questa
popolazione di grandi viaggiatori, artigiani, vasai e metallurghi sono i
brassard, o guardamano, ingegnosi oggetti di pietra e osso che servivano a
proteggere il polso dal rimbalzo della corda dell'arco. Questa popolazione
brachicefala (il che fa supporre un'origine non mediterranea, forse da
ricercarsi nell'Anatolia interna e nelle regioni del Mar Caspio e del Mar
Nero) si diffonde comunque in Europa a partire dalla Spagna: il che,
aggiungendosi alle loro abitudini vagabonde, ha contribuito a far battezzare
queste genti "gli zingari della preistoria". La loro presenza è attestata
dovunque: nella penisola iberica come in Inghilterra, nella Scandinavia come
in Russia, nell'Europa centrale come in Italia, sempre accompagnata dall'immancabile
bicchiere a campana. In Sardegna, dove la loro frequentazione è specialmente
ma non esclusivamente attestata nel triangolo Porto Torres-Sassari-Alghero,
tutti i ritrovamenti concorrono ad avvalorare l'ipotesi che le genti del
campaniforme siano state, come altrove, accolte pacificamente e assimilate
all'interno delle comunità prenuragiche, ricevendo sepoltura nelle stesse
necropoli degli ospiti. La necropoli di Su Crucifissu
Mannu ha poi, all'interno del nostro itinerario, un secondo motivo di grande
interesse. L'area fu infatti utilizzata in epoca romana, come dimostrano i
solchi profondamente incisi sulla superficie della roccia
calcarea: sono tracce evidenti del passaggio, regolare e frequente, di
carri e veicoli da trasporto, diretti con ogni evidenza alla vicina, vitale
colonia romana di Turris Libisonis per approvvigionarla di derrate agricole
provenienti dalla retrostante campagna o, forse, di materiale da costruzione. 4. Porto Torres: Ponte romano. Ancor più logico dunque che la
nostra prossima tappa sia appunto Porto Torres, città oggi dall'aspetto non
troppo invitante, che nasconde con understatement perfino eccessivo le sue
glorie e i suoi tesori archeologici agli occhi del viaggiatore di passaggio.
Questa fu in effetti, per importanza, vitalità commerciale, popolosità e
floridezza, la seconda città romana di Sardegna dopo Karales (Cagliari), una
delle due cui facevano capo le principali arterie della fittissima rete
viaria romana: in particolare la strada che, seguendo un tracciato in gran
parte identico a quello dell'attuale Carlo Felice, attraversava l'isola da
sud a nord, da Karales a Turris, e quella costiera che, passando per Tibula
(Santa Teresa Gallura o Castelsardo), metteva in comunicazione i due più
importanti porti del Nord Sardegna, Turris e Olbia. Il ponte romano oggetto
della nostra prima visita nella città turritana faceva però parte di una
terza strada, anch'essa di vitale importanza, che collegava il porto di
Turris alla zona agricola della Nurra interna e a quella mineraria della
costa occidentale, terminando nei pressi dell'attuale Alghero. Opera di
notevole livello ingegneristico e monumentale, il ponte, lungo 135 metri e
formato da sette arcate costruite su pile erette con blocchi di calcare, è
probabilmente databile all'età augustea. Sotto le arcate minori si
conservano i resti dell'originaria pavimentazione in trachite. La solidità
della struttura è comprovata dal suo uso ininterrotto per secoli: solo in
anni recenti, infatti, il ponte è stato chiuso al traffico motorizzato. In
precedenza vi transitavano perfino gli autotreni che assicuravano i
collegamenti fra il porto e il polo petrolchimico. 5. Porto Torres: Colonia
romana di Turris Libìsoms e Antiquarium Turritano. A dimostrazione che
effettivamente tutte le strade portano, o almeno portavano, a Roma, quelle
che confluivano a Turris, interrotte temporaneamente dal mare, riprendevano
a Ostia, un paio di centinaia di miglia più ad est, dove le derrate agricole
imbarcate qui venivano scaricate per essere trasportate nell'Urbe. A Ostia,
infatti, esisteva una sede di commercianti di Turris, testimoniata da un
mosaico dove si fa menzione dei navicularii turritani, che contribuivano con
le loro navi cariche di grano all'approvvigionamento alimentare di Roma. Dall'importanza del suo porto
possiamo logicamente dedurre l'estensione della Porto
Torres: gli imponenti resti della colonia romana di Turris Libisonis Non una metropoli, ma senza
dubbio una popolosa città rivierasca, cui Roma concesse, forse fin dai tempi
di Giulio Cesare, lo statuto di colonia romana, con propri magistrati
elettivi. Di questa grande città rimangono tracce notevoli, anche se quello
che è stato riportato alla luce è certamente ben poco rispetto a quanto è
sepolto sotto i molteplici strati delle epoche successive. In particolare,
nei pressi della stazione ferroviaria, si conservano i resti di diversi
edifici termali, il più imponente dei quali è il cosiddetto "Palazzo di
Re Barbaro", completamente delimitato da strade lastricate e con ampi
saloni: il frigidarium (sala con vasche per il bagno freddo, decorata con
mosaici policromi) e i contigui locali dei tepidario (ambienti con calore
moderato) e del calidarium (ambiente caldo). Notevoli i resti di un porticato
parzialmente restaurato e di una galleria con volta (criptoportico). Nella
stessa area sorge l'Antiquarium Turritano, importante museo nazionale
inaugurato alla metà degli anni 80, che ospita la ricca collezione comunale
di oggetti e reperti di età nuragica, greca, punica, romana e bizantina.
L'edificio è disposto su due piani. Al piano terreno vi è una prima sala di
esposizione con vetrine contenenti materiali provenienti da scavi compiuti in
vari punti della città e dei dintorni: al centro della sala un'ara di marmo
decorata a rilievo, dedicata alla dea Bubasti (divinità egizia con la testa
di gatta). Sulla cornice sono incisi i
nomi di Marco Servilio e di Gaio Cestio, i due consoli in carica nel 35 d.C.
(anno della consacrazione del monumento). L'altare, oltre che per le qualità
artistiche, è importante per la ricostruzione della storia della città: testimonia
infatti l'esistenza di un culto delle divinità egizie nella prima metà del I
secolo d.C. Al piano superiore sono esposti i pannelli e i reperti relativi
ai complessi termali di via Ponte Romano e alle necropoli più antiche. Vi
sono inoltre reperti marmorei e ceramici della collezione comunale. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||