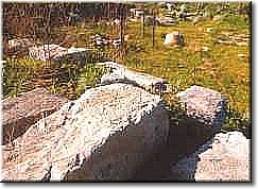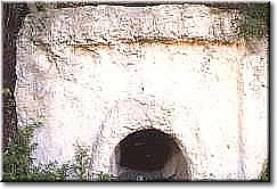|
1. Sassari:
Museo archeologico nazionale G.A. Sanna.
Insieme con quella del Museo nazionale di Cagliari, la collezione archeologica
del Museo Sanna è la più importante e ricca della Sardegna. Posto su via
Roma, in una palazzina ispirata al gusto neoclassico con un grazioso
giardino, il museo fu riordinato negli anni Settanta con forti intenti
didattici e corredato di modellini, tavole cronologiche, grafici e pannelli
esplicativi. La struttura, molto grande, su più piani, comprende una sezione
archeologica, una etnografica (attualmente chiusa) e una pinacoteca. In
quest'ultima, frutto in gran parte di una donazione del mecenate sassarese
cui il museo è intitolato, sono esposti alcuni pregevoli dipinti del XIV -
XVIII secolo, oltre a collezioni di opere più moderne. La sezione
archeologica è naturalmente quella di maggiore interesse. Vi spicca la sala
dedicata interamente all'altare preistorico di Monte d'Accoddi, straordinario
monumento situato a pochi chilometri da Sassari, databile tra la fine del
Neolitico recente e la prima Età del Rame (2700-2400 a.C.) e simile per
struttura alle ziqqurat mesopotamiche. Ricca e suggestiva la collezione di
bronzetti nuragici, provenienti da vari siti sparsi per tutta la provincia di
Sassari (e anche da alcuni nuraghi della provincia di Nuoro) e altrettanto
affascinante quella dei reperti ritrovati nelle domus de janas. Le due sale
di archeologia romana sono a loro volta di assoluto interesse, anche perché
in questo museo veniva raccolto, prima dell'apertura nel 1984
dell'Antiquarium Turritano, tutto il materiale artistico ed epigrafico
proveniente da Porto Torres, cioè dalla colonia romana di Turris Libisonis.
Attualmente un po' sacrificata la sala di archeologia medievale, della quale
è previsto un prossimo ampliamento.
2. Sorso: Santuario nuragico di Serra Niedda.
Si esce da Sassari lungo la statale 200 per Castelsardo e, raggiunta in una
decina di minuti Sorso, si prosegue per la stessa strada in direzione di
Castelsardo fino a incontrare, dopo circa due chilometri, l'articolata area
sacra nuragica di Serra Niedda. Riportato alla luce da una serie di campagne
di scavi effettuate fra il 1985 e il 1988, il Santuario nuragico di Serra
Niedda presenta una serie di strutture, non tutte di facile o sicura
interpretazione, la più interessante delle quali è 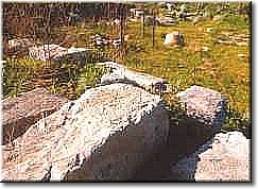 costituita da un pozzo sacro con camera circolare, cui si accede
scendendo una rampa semicircolare di 14 gradini costruiti in lastre di
calcare, ad eccezione dei tre inferiori, ricavati nella roccia. costituita da un pozzo sacro con camera circolare, cui si accede
scendendo una rampa semicircolare di 14 gradini costruiti in lastre di
calcare, ad eccezione dei tre inferiori, ricavati nella roccia.
Sorso: il santuario nuragico di Serra Niedda
Il sito,
che attende ancora, nonché una valorizzazione, una sistemazione storico -
critica adeguata, ha restituito una notevole quantità di reperti bronzei, fra
i quali spicca per la sua importanza un modellino di nuraghe a quattro torri,
di cui quella centrale sormontata da una figura di colomba stilizzata.
Esposto al Museo Sanna di Sassari è un altro celebre bronzetto proveniente da
questo sito e raffigurante un capotribù che porta al guinzaglio un ariete.
3. Sennori:Domus de janas dell'Orto del Beneficio Parrocchiale.
Rientrati a Sorso, raggiungiamo il centro dell'adiacente cittadina di Sennori
dove, accanto alla chiesa parrocchiale, visiteremo un gruppo di tombe
ipogeiche scavate nella roccia calcarea, ascrivibili alla Cultura di Ozieri
(3500-2700 a.C.) e di notevole interesse sia per le figurazioni che compaiono
in una di esse sia per lo schema anomalo, disordinato e privo di simmetria,
della loro pianta complessiva. Il sito comprende in tutto undici ambienti, ad
alcuni dei quali si accede attraverso un ingresso sopraelevato. In uno di
questi, su una parete suddivisa in riquadri rettangolari da lesene, sono
scolpite in bassorilievo tre protomi taurine (corna di toro: simbolo forza
riproduttrice della natura) di fattura accurata e regolare, ciascuna delle
quali si prolunga verso il basso in una testa estremamente stilizzata. La
singolare ubicazione al centro dell'abitato attuale non ha purtroppo giovato
a queste suggestive sepolture preistoriche che, oltre a versare in un cattivo
stato di conservazione, sono state deturpate da atti di vandalismo.
4. Sennori: Tomba di giganti di Oridda.
Da Sennori s'imbocca la provinciale per Nulvi e dopo poco più di cinque
chilometri si svolta a destra per Osilo: circa quattro chilometri dopo questo
bivio, proprio accanto al margine destro della strada e tuttavia difficile da
individuare, si trova la Tomba di giganti di Oridda, sepoltura collettiva di
epoca nuragica (al suo interno furono ritrovati i resti di 27 individui), cui
si accede attraverso una stele quadrangolare entro la quale è praticato un
portello e che è preceduta da un lungo corridoio o dromos di circa sei metri
e mezzo, fiancheggiato da muri a secco rastremati verso l'atto. 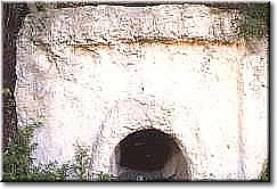 Il corridoio sbocca, dinanzi alla stele, in un'ampia esedra
delimitata da pietre confitte verticalmente nel terreno (ortostati). Il corridoio sbocca, dinanzi alla stele, in un'ampia esedra
delimitata da pietre confitte verticalmente nel terreno (ortostati).
Sennori: la
tomba di giganti di Oridda
La particolarità
della Tomba di Oridda, che la differenzia da tutte le altre tombe di giganti
conosciute, è data dal fatto che alta facciata di tipo dolmenico -
ortostatico, tipica delle tombe di giganti, si unisce un vano ipogeico legato
alla tradizione dette domus de janas, con il pavimento ribassato di oltre
mezzo metro rispetto al terreno circostante.
5. Osilo: Domus a prospetto architettonico di Ittiari.
Da Oridda
si prosegue lungo la provinciale per Osilo e, qualche chilometro prima di
raggiungere il paese, si imbocca la strada a scorrimento veloce dell'Anglona
in direzione di Sassari: al secondo viottolo si gira a destra e si prosegue
fino al secondo incrocio, quindi a sinistra fino al passaggio a livello. Di
qui, lasciata l'auto, dovremo proseguire a piedi per circa un quarto d'ora,
fino a veder apparire sulla sinistra del sentiero, allineate ad arte
sull'alto fronte del costone di roccia calcarea, le scenografiche Domus de
janas di Ittiari. Le tombe sono del tipo "a spartito centinato",
caratterizzate dall'abbinamento della sepoltura ipogeica prenuragica con
motivi scolpiti nella roccia viva, che ricordano molto da vicino le stele e
le esedre tipiche delle tombe di giganti di epoca nuragica. L'archeologo
Giovanni Lilliu ipotizza che questi monumenti possano risalire a una fase di
transizione fra civiltà prenuragica e nuragica (Cultura di Bonnanaro,
1800-1600 a.C.), mentre secondo un altro studioso, Ercole Contu, si
tratterebbe di vere e proprie tombe di giganti che riutilizzano precedenti
sepolture. Resta il fatto che questo particolare tipo di tomba è
particolarmente attestato in un'area piuttosto ristretta del Sassarese, di
cui Osilo costituisce il Limite nord - orientale.
6. Nulvi: Nuraghe e Tempio a pozzo nuragico di Irru.
Ritrovata la strada provinciale, si raggiunge la vicina Osilo e di qui si
prende un'altra altra bella strada, tortuosa ma panoramica, la statale 127,
in direzione di Nulvi e Tempio. Oltrepassato l'abitato di Nulvi, capoluogo
comunale di uno dei territori a più alta densità di nuraghi di tutta La
Sardegna, si procede ancora per circa tre chilometri verso Tempio, fino a
incontrare sulla destra la deviazione, ben segnalata, per l'area archeologica
di Irru. Il Nuraghe Irru fu rinvenuto alla fine del 1988 durante i lavori per
la ricerca di una falda acquifera: il monumento era completamente ricoperto
dalla terra. L'insieme consta di un nuraghe a pianta complessa e di un
villaggio attiguo. A qualche centinaio di metri un tempio a pozzo,
caratterizzato da una raffinata architettura a tecnica isodoma con conci in
calcare. I materiali rinvenuti, che testimoniano di una lunga e ripetuta
riutilizzazione del sito, risalgono a tre periodi: all'epoca nuragica
(1600-800/700 a.C.), all'età fenicio - punica (VI secolo a.C.) e oll'alto
Medioevo. IL complesso svolgeva un importante ruolo nel territorio perché
situato in una zona pianeggiante, in prossimità di un corso d'acqua e di vie
di penetrazione. La sua economia, basata sulla pastorizia, sull'agricoltura e
sull'estrazione del rame dalle località vicine, permetteva ai nuragici un
notevole scambio con i prodotti del mercato esterno (fenicio, punito e
greco).
7. Tergu: Muraglia e villaggio nuragico di Monte Elias.
Tornati
sulla statale 127, ne percorriamo un breve tratto a ritroso fino a incontrare
sulla destra il bivio per Tergu, che dista da questo punto circa dodici
chilometri: poche centinaia di metri prima di entrare nell'abitato di Tergu,
si stacca sulla sinistra della provinciale una carrareccia che conduce
direttamente al Monte Elias, colle trachitico sulla cui vetta, a 316 metri di
altitudine, si ergono i resti imponenti di una poderosa muraglia nuragica,
particolarmente sviluppata sul lato nord, proprio sul ciglio della rupe. Le
mura, delle quali si può tuttora apprezzare uno sviluppo longitudinale di ben
120 metri, con un'altezza massima di cinque, furono erette a difesa di un
villaggio, del quale sono visibili sparse e modeste rovine. Nell'area sono
stati rinvenuti oggetti d'arredo d'epoca romana, segno di una prolungata
riutilizzazione del sito originario.
8. Castelsardo: Muraglia megalitica di Monte Ossoni.
Da Tergu si prosegue in direzione di Castelsardo e, giunti a meno di due
chilometri dal mare di Lu Bagnu, si svolta a destra in direzione di Multeddu:
raggiunta questa frazione, si piega a sinistra nella statale 134 per
Castelsardo e dopo circa un chilometro a destra in un lunghissimo e tortuoso
sterrato che in circa 20 chilometri conduce fino alla cima di Monte Ossoni,
difesa in epoca preistorica da un'opera megalitica dall'aspetto possente.
Sulla base del ritrovamento di alcune ceramiche e di altri reperti il
complesso di Monte Ossoni (Monte Solare) viene fatto risalire alla Cultura
eneolitica di Monte Claro (seconda metà del terzo millennio a.C.). La
muraglia, costruita con macigni di grandi dimensioni, è lunga 58 metri e alta
2,4 metri, ed è orientata a nord - est con andamento convesso. Generalmente
confusa con un nuraghe, è in realtà una cinta di difesa all'interno della
quale si trovava un abitato preistorico. Di qui, ritornati sulla statale 134,
si raggiunge Castelsardo.
|