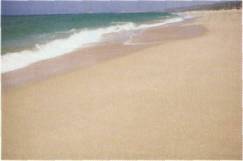Il territorio del Nord Sardegna
Con
oltre 7500 chilometri quadrati di superficie la provincia di Sassari è la più
grande d'Italia: la sua estensione è pari a quasi una volta e mezza quella dell'intera
Liguria e di poco inferiore a quella del Friuli-Venezia Giulia. Queste
dimensioni danno ragione soltanto in parte della non comune varietà di
paesaggi, di ambienti culturali e sociali, di tesori archeologici e
architettonici che il Nord Sardegna offre al visitatore. La
varietà è del resto un elemento caratterizzante del territorio della Sardegna
nel suo insieme, una delle qualità del paesaggio che più colpiscono l'ospite
anche all'esplorazione superficiale. Tolta la pianura del Campidano, che
taglia diagonalmente tutto il sud dell'isola, da Cagliari a Oristano, non
esiste in Sardegna alcun comprensorio significativamente esteso al cui
interno non siano avvertibili forti e improvvisi mutamenti di profili, di
forme, di colori. Anche i segni della presenza umana sono d'intensità
diseguale: benché le zone fertili e relativamente ricche d'acqua,
antropizzate da millenni, siano più frequenti di quanto comunemente si
creda, è pur vero che in ben poche regioni europee capita altrettanto sovente
di attraversare lunghi tratti di natura all'apparenza intatta, dove nessun
edificio, nessun coltivo, nessun animale domestico vengono a interrompere il
dominio del bosco, della macchia e delle rocce affioranti. All'interno
del territorio del Nord Sardegna una prima cesura si rende evidente, tanto
dal punto di vista geologico e morfologico quanto da quello antropico, fra il
Logudoro, che occupa tutta la parte occidentale e centro-meridionale della
provincia, e la Gallura a nord-est. Il confine fra queste due vaste
sub-regioni, nettamente marcato nel tratto settentrionale dal corso del fiume
Coghinas, si fa un po' più vago e ondeggiante via via che si procede verso
sud: la linea di demarcazione serpeggia allora lungo le creste granitiche
del massiccio del Limbara, orientale da sud-ovest a nord-est, quindi scende
per Telti e Monti verso la provincia di Nuoro seguendo grosso modo il
tracciato della statale 389. Benché il granito costituisca uno dei caratteri
forti del paesaggio gallurese, la natura geologica dei suoli non è un
criterio dirimente nel disegnare questo confine: basti pensare che l'immenso
altipiano di Buddusò, i Monti di Ala, il vasto territorio comunale di
Berchidda (tutte zone dove il granito domina incontrastato) fanno storicamente
parte del Logudoro, mentre un caso particolare è costituito dal comune di
Padru, il cui territorio giace in piena Gallura, addirittura quasi a ridosso
della costa orientale, ma che fino al 1996, cioè fino all'ottenimento
dell'autonomia comunale, costituiva un'isola amministrativa del comune
logudorese di Buddusò. Al di là
di queste incertezze e parziali sovrapposizioni, le differenze
paesaggistiche, storiche, linguistiche, economiche fra le due regioni
restano profonde. Contrariamente al Logudoro, che ha conosciuto una
frequentazione umana intensissima fin dalle età più remote e una compresenza,
già in epoca preistorica, di agricoltura e pastorizia, la Gallura è stata
sempre segnata da un destino di solitudine, con pochi e isolati
insediamenti, da un'economia pressoché esclusivamente di tipo pastorale e
da lunghissimi periodi di spopolamento totale dei litorali. Le vicende di
questo secondo dopoguerra hanno in qualche misura attenuato la disparità
fra le due regioni o, piuttosto, l'hanno resa meno marcata e meno facile da
cogliere ad un'osservazione superficiale: da una parte, infatti, il forte
flusso migratorio degli anni Sessanta e Settanta, con il conseguente
abbandono generalizzato delle campagne, ha molto mortificato la vocazione
agricola di vasti comprensori del Logudoro (come l'Anglona e il Meilogu)
provocando quasi dovunque una schiacciante prevalenza dei pascoli sui
coltivi; dall'altra
lo sviluppo turistico, particolarmente rapido e tumultuoso sulla costa
orientale e nordorientale, ha avuto il duplice effetto di compensare il
divario economico e demografico fra le due regioni e di mascherare sotto la
continuità a tratti perfino soffocante degli insediamenti turistici quella
singolare rarità dei presidi litoranei che, in precedenza, costituiva uno
degli elementi più caratteristici della costa gallurese. |
|
Queste recenti
trasformazioni del paesaggio, relativamente profonde lungo i litorali (ma
con notevoli eccezioni specie sulla costa occidentale, nel tratto a sud di
Alghero, e su quella settentrionale nella sua parte gallurese, da Badesi ad
Aglientu), si fanno via via meno incisive e spesso irrilevanti procedendo
verso l'interno, dove il territorio ha conservato sostanzialmente intatti i
suoi caratteri originari. In
Sardegna più che altrove (e in Gallura in misura ancor più macroscopica che
nel resto della Sardegna) un effetto paradossale del turismo di massa, con
la sua destinazione pressoché esclusivamente balneare, è stato quello di
portare il visitatore proprio nei luoghi che dalla popolazione indigena erano
stati, nei secoli, più costantemente evitati: luoghi
poveri di storia e, a dispetto della loro straordinaria ricchezza di bellezze
naturali, del tutto artificiosi dal punto di vista urbanistico e
antropologico. Il bagnante sta, in modo quasi simbolico, di fronte al mare,
dando le spalle al territorio, alla sua complessità e varietà, e ad ogni
reale possibilità di comprensione degli agenti, naturali e umani, che hanno
dato forma al paesaggio. Perfino quel che di autenticamente tipico gli viene
offerto, nelle botteghe degli artigiani o nei ristoranti, appartiene a una
tipicità che risiede altrove, in qualche punto dell'isola più o meno lontano
ed ignoto, e ha dovuto viaggiare poco o tanto per raggiungere quelle località
costiere dalle quali in passato si era sempre mantenuto a rispettosa distanza.
Ne consegue che il turista, a meno che sia fortemente motivato a spingersi
nell'interno dell'isola da passioni o curiosità personali, non riesce a
formarsi, al termine della vacanza, alcuna idea precisa dell'isola che l'ha
ospitato e neppure della porzione di territorio immediatamente retrostante la
spiaggia in cui ha soggiornato. Per offrire una prima agile possibilità di orientamento negli oltre 7500 chilometri quadrati del Nord Sardegna, queste pagine introduttive cercano di descrivere in estrema sintesi le specificità locali delle varie porzioni di territorio in cui questa vasta regione può essere suddivisa, sia sulla base delle caratteristiche morfologiche del paesaggio sia sul filo delle vicende storiche che sono venute tracciando nei secoli confini non ufficiali, ma più marcati di quanto il visitatore sia portato a credere. In Sardegna in generale, e nel Nord Sardegna in particolare, sono tuttora molto più vivi che altrove, e utilizzati nella lingua d'ogni giorno, i nomi storici delle sub-regioni di cui l'isola si compone. Due di questi nomi, Logudoro e Gallura, sono già stati introdotti fin dall'inizio. Ma, mentre la Gallura ha caratteri di omogeneità tali da non aver generato ulteriori frammentazioni (si distingue tutt’al più fra un'Alta Gallura interna e una Bassa Gallura costiera), all'interno del Logudoro le tipicità locali si sono per cosi dire istituzionalizzate, benché i corrispondenti toponimi non rivestano più oggi alcun valore amministrativo. Da nord
a sud e da ovest a est si distinguono dunque, nella provincia di Sassari, le
seguenti principali regioni storico-geografiche: Nurra, Paese di Villanova, Romangia, Sassarese,
Meilogu, Anglona,
Montacuto, Goceano
e Gallura. Una breve rassegna dei motivi di attrazione che ciascuna di
queste realtà Locali offre al turista potrà fornire al lettore un primo utile
strumento di conoscenza, aiutandolo ad orientarsi nel territorio e a scegliere,
sulla base e delle sue curiosità personali e della sua dislocazione nello
spazio, uno o più degli approfondimenti proposti nelle due successive sezioni
della Guida: quella dedicata agli Itinerari e quella incentrata
sui Comuni. |
|
|
|
|